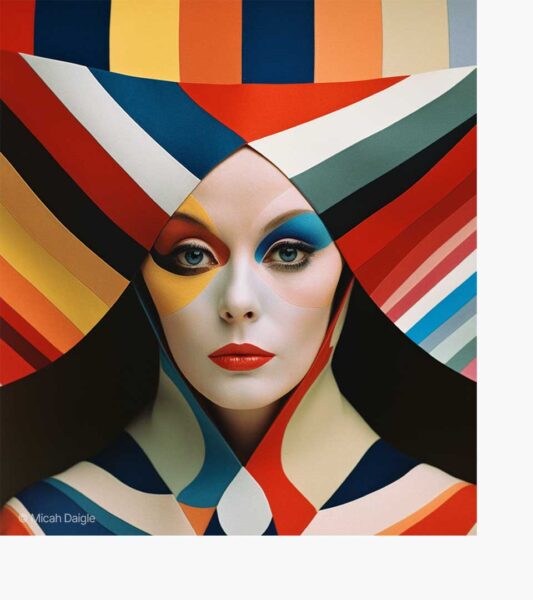Ci sono versi che non accarezzano ma destano, parole che non promettono evasione ma ritorno a sé stessi. La poesia di Bertolt Brecht appartiene a questa famiglia di parole necessarie: ruvide e lucide, scomode e luminose.
È una poesia che non consola ma chiarisce, che non nasconde le ferite ma le guarda come parte della forma, come un segno di grazia che ha imparato a convivere con le unghie.
Brecht non è un poeta “di bellezza” nel senso convenzionale del termine: usa la bellezza come uno specchio per riconoscersi, non per ammirarsi. Le sue poesie, nate tra guerra ed esilio, sono finestre sulla realtà e sul modo in cui possiamo restare autentici anche quando tutto intorno perde forma.
Scrivere, per lui, non era mai un gesto decorativo. Nato nel 1898 ad Augsburg, in una Germania in trasformazione, attraversò la guerra, la censura, la fuga. Ogni parola fu un atto di presenza nel mondo, un modo per capire e non accettare passivamente la crudeltà del tempo. “Non basta guardare, bisogna anche pensare”, scriveva. È il cuore del suo celebre effetto di straniamento, un invito a restare vigili, a non perdersi nell’emozione ma a trasformarla in coscienza.
Una lezione che parla anche a noi, in un’epoca in cui cerchiamo equilibrio tra ciò che sentiamo e ciò che mostriamo, tra interiorità ed esteriorità.
Un giorno, osservando un piccolo leone di pietra cinese, Brecht disse:
“I cattivi temono le tue unghie. I buoni si rallegrano della tua grazia. Una cosa così mi piacerebbe sentire dei miei versi.”
In questa frase si racchiude la sua idea di bellezza: la grazia come misura e delicatezza, le unghie come verità e coraggio. È l’armonia tra eleganza e forza, la stessa che cerchiamo nella vita: essere autentici senza essere duri, forti senza diventare freddi, belli senza smettere di essere veri.
Le poesie di Brecht sono spoglie, precise, essenziali. Ogni parola è un gesto misurato. La bellezza, per lui, non è perfezione ma coerenza tra dentro e fuori, tra ciò che crediamo e ciò che mostriamo.